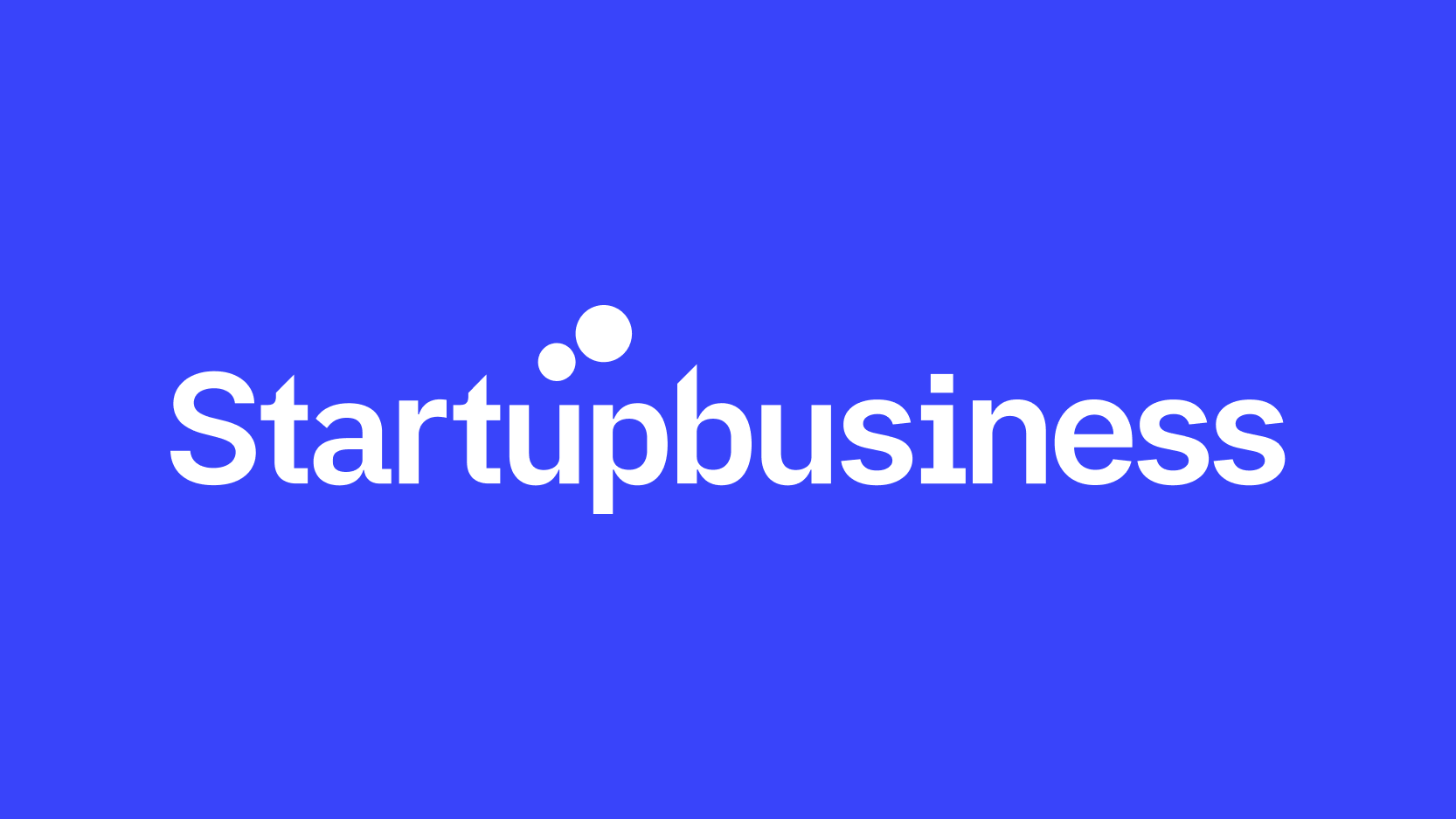Abbiamo fatto il contrario di quello che consigliano tutti i manuali del giovane startupper: non abbiamo fatto nessun business plan e nessun convincente pitch da 5 minuti. Don’t try this at home!
Marco Bocola, 32 anni, laureato in Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano, professione “maker”. E imprenditore. Ha co-fondato Vectorealism, startup che permette di ordinare online e realizzare oggetti di design personalizzati, la cui produzione utilizza innovative tecniche di taglio laser.
Praticamente un FabLab on-demand.
Marco ha collaborato con Fondazione Irso, occupandosi tra l’altro di ricerca sulla storia della Olivetti e di consulenza su temi organizzativi. Oltre ad essere ideologo di Vectorealism, si occupa di risorse umane per il gruppo TWT.
Dal reale al virtuale e ritorno. Soprattutto ritorno, direi. Quando abbiamo scelto il nome Vectorealism, insieme a Eleonora (Eleonora Ricca, co-founder), avevamo ben chiara un’intuizione: gli anni 2000, dominati dallo sforzo collettivo di digitalizzazione dell’esistente, erano ormai finiti. E con essi la frenesia di scannerizzare documenti e foto, acquisire videocassette, convertire cd in mp3, riempire fino all’orlo gli hard disk. Stavamo assistendo al fallimento di Blockbuster e della Kodak, due degli attori più influenti della storia dei consumi di massa. Una nuova generazione cresceva sviluppando idee e progetti direttamente in digitale, spesso per il puro gusto di conviderli. Fotografie scattate in digitale e mai stampate. Musica fatta con un macbook e mai suonata dal vivo. Rendering fotorealistici di oggetti disegnati e mai prodotti.
Eppure l’invasione degli oggetti nelle nostre case non sembrava arrestarsi. Era il 2009, e mi capitava spesso di pranzare con Eleonora, vicino al suo ufficio. Lei lavorava in una grande agenzia di comunicazione, in piena Chinatown a Milano e succedeva spesso che mi facesse da guida turistica tra i bazar straripanti di oggetti di plastica. La scritta “Designed in California, Made In China” che campeggiava sui nostri ipod cominciava a suonarci sinistra, e volevamo fare qualcosa per cambiare le cose.
Né lei né io ci sentivamo “startupper”. Avevamo soltanto rabbia, idee, incosciente ottimismo. E un piccolo bottino che Eleonora aveva da poco vinto a un quiz televisivo a cui l’ho iscritta; non aveva visto mai nemmeno una puntata del programma, ha finito per vincerne 3 di seguito.
Ci siamo chiesti cosa fosse davvero necessario per produrre degli oggetti, rifiutandoci di credere che non esistano alternative alla Cina o al sistema manifatturiero brianzolo ossessionato dal lusso e dalla ricchezza. Ci siamo innamorati dell’idea dei piccoli laboratori FabLab, che promettono di produrre “quasi qualunque cosa” con una manciata di macchine.
Allo stesso tempo, volevamo che queste idee potessero diventare un lavoro vero, sostenersi negli anni. Per questo era necessaria un’attrezzatura professionale e un canale di vendita efficace. Con una secchiata d’incoscienza li abbiamo acquistati entrambi, riuscendo a non chiedere un euro di prestito a nessuno. E siamo partiti.
Abbiamo fatto il contrario di quello che consigliano tutti i manuali del giovane startupper: non abbiamo fatto nessun business plan e nessun convincente pitch da 5 minuti. Come direbbero gli americani: don’t try this at home! Ma credo che ogni impresa debba trovare il giusto equilibro tra razionalizzazione (e la burocrazia che spesso ne consegue) e guizzo (con la conseguente moltiplicazione dei rischi).
Insomma, ci siamo buttati nel business del DIY (do it yourself) con un approccio DIY. Mi piacerebbe poter dire che è stata soltanto una scelta ideologica quella di fare tutto da soli, ma in realtà si è trattato di una via praticamente obbligata. Tutti i bandi e concorsi dedicati alle startup sembrano fondati sull’idea stereotipata del programmatore che sviluppa “il nuovo Facebook” nella sua cameretta. Spesso i premi in palio sono poche migliaia di euro, un po’ di formazione e nella migliore delle ipotesi una scrivania in uno spazio condiviso. Fortunatamente esistono anche le eccezioni, come Made in Mage, l’incubatore “atipico” dove siamo da qualche mese. Si tratta di un ex capannone industriale Falck con tanto spazio, tetto alto e corrente a 380: l’ideale per aumentare ancora i volumi della nostra produzione e aggiungere magari altre macchine.
Una cosa è certa: forse non siamo ancora riusciti a diventare una no slides company, ma teniamo duro sulla nostra idea visionaria di consentire a chiunque di rendere tangibili le sue idee. L’attenzione che si sta concentrando sul mondo dei maker ci dà ragione e ottimismo. Make things, not slides!
http://www.vectorealism.com/
© RIPRODUZIONE RISERVATA